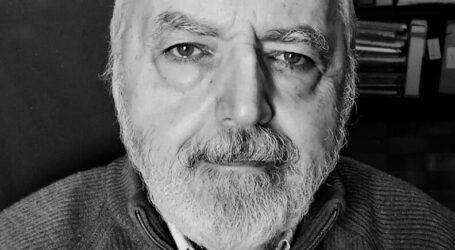La Pasqua della galina grisa
Di Pier Luigi Feltri
Romagnese si adagia nell’alta Val Tidone, tra le ultime propaggini dell’Oltrepò pavese e il confine emiliano, a 600 metri d’altitudine. Un luogo di transito e di incontro, dove le tradizioni si stratificano, mescolan- dosi con quelle della Val Trebbia e delle Quattro Province. La sua posizione, distante dai grandi centri ma in passato di frontiera, ha reso possibile che qui si conservassero usanze antiche e altrove perdute. Come quella della Galina Grisa. Con questo nome il paese chiama le celebrazioni del Triduo Pasquale: un ciclo rituale che affonda le radici nelle questue medievali e nelle usanze di Calendimaggio. Tutto comincia il Giovedì Santo, con la Messa delle 20 e la processione, che parte dalla chiesa parrocchiale e raggiunge la frazione Casa Picchi, dove sorge un oratorio dedicato alla Vergine. È un momento di intensa partecipazione. Mentre le fiaccole accese lungo il percorso evocano un’atmosfera solenne e antica, un anonimo penitente guida il cammino trasportando una grande croce di legno. Porta un lungo mantello rosso e ha il volto incappucciato. Inoltre, la serata del giovedì è usualmente arricchita da raffigurazioni interpretative dei momenti pasquali. Il Venerdì Santo la comunità si raccoglie per la processione del Cristo morto. A rendere unico l’evento sono i falò accesi nei borghi della valle. Un tempo queste pire erano il segnale visibile della celebrazione, un linguaggio di fuoco che collegava le varie località in una competizione non dichiarata: chi avrebbe avuto le fiamme più alte, chi avrebbe saputo prolungare più a lungo la luce nella notte? I fuochi accesi nel buio simboleggiano il chiarore che riemerge dalle tenebre, così come la primavera rinasce dall’inverno, così come il Cristo ritorna dalla morte. Sabato è il giorno più atteso. Dopo la celebrazione religiosa delle 17, gruppi di uomini si riuniscono e iniziano il giro notturno delle frazioni intonando canti, accompagnati dalle melodie dei pifferi e degli altri stru- menti tradizionali. La prima strofa è sempre quella della “Galina Grisa”, il canto che dà il nome alla festa e che accompagna la raccolta casa per casa delle uova che vengono utilizzate per preparare, a fine itinerario, la caratteristica frittata in piazza, dove la festa prosegue fino a notte inoltrata. La Galina Grisa non è solo questione di folklore: è un ponte tra passato e presente, oltre che testimonianza di una fede secolare. Anno dopo anno ribadisce l’identità di una comunità che non scorda le proprie radici.
pierluigi.feltri [at] gmail.com