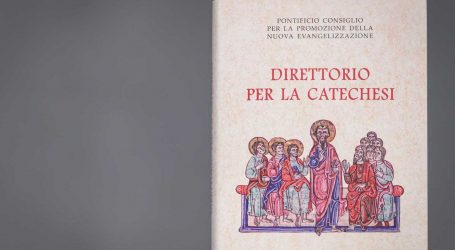Se i tuoi figli sono hikikomori
Adolescenti. Molti di loro vivono momenti di difficoltà e di incertezza del futuro. E dai 14 anni in su cresce il fenomeno dei “ritirati sociali”, coloro che tendono a tagliare i ponti con il mondo. Una tendenza che non possiamo ignorare, analizzata da Morena Dabusti, psicologa e psicoterapeuta
di Marco Rezzani
Le nuove generazioni, in particolare gli adolescenti, vivono anni di difficoltà, in cui il tratto distintivo sembra essere l’incertezza del futuro. Davanti a situazioni molto più grandi di loro, quali pandemia e guerra alle porte di casa, si riscoprono fragili. In questo contesto aumentano le condizioni di disagio sociale e psicologico. Tra di esse merita un posto di rilievo il fenomeno degli “hikikomori”, i “ritirati sociali”, coloro che tendono a tagliare i ponti con il mondo.
Ne abbiamo parlato con Morena Dabusti, psicologa e psicoterapeuta, impegnata sul fronte giovanile e famigliare nella scuola e in diocesi.
«Con il termine hikikomori – spiega la Dabusti – si intende un fenomeno, originariamente attribuito alla cultura giapponese e poi riconosciuto in tutti i Paesi economicamente più sviluppati del mondo. L’espressione è utilizzata per descrivere un assetto comportamentale riscontrato tra i giovani, tendenzialmente tra i 14 e i 30 anni, contraddistinto dal ritiro dalla vita sociale. Deriva dal giapponese hiku (tirare indietro) e komori (ritirarsi). L’isolamento, la passività e l’indifferenza dal reale sono i tratti che contraddistinguono questi ragazzi, impegnati a raggiungere un “anonimato” rispetto al contesto di vita familiare, scolastico e amicale. La loro è una silente protesta che va interpretata, innanzitutto, come specchio e paradosso della nostra contemporaneità, intrisa di tensioni e fragilità. Per questo il fenomeno hikikomori merita di essere considerato sia nella dimensione intima ed individuale del ragazzo, sia in quella sociale. Apre scenari e interrogativi dentro e fuori la persona. Per “uscire” cosa mi occorre? Chi trovo? Cosa si aspettano da me? Spesso si innesca una demotivazione progressiva a confrontarsi con la vita sociale, che raggiunge il rifiuto. Il ritiro o la “dipendenza” dal virtuale, in questo senso, appare come conseguenza e non causa dell’isolamento, come a colmare virtualmente una realtà che suscita impotenza e perdita di controllo. Comprendiamo quanto il fenomeno sia complesso e apra a riflessioni profonde che ci coglie in parte impreparati, in parte ci obbliga a guardare e confrontarci con una forma silenziosa e buia che coinvolge tutta la società contemporanea».

Quali sono le cause?
«Sono molteplici, e in via di studio, i fattori che possono essere attribuiti a un nesso di causalità con il fenomeno hikikomori. Per elencarne alcuni, il disagio sociale e familiare, gli stili educativi iperprotettivi/dipendenti e le pressioni sociali. È stata rilevata anche una possibile connessione con fenomeni di bullismo subiti. Il progressivo distacco dal contesto scolastico, fino all’assenteismo, è stato indicato come un precursore hikikomori, nel 69% dei casi. Riferimenti sono stati fatti anche al temperamento sensibile e introverso del ragazzo e alla fragilità e insicurezza».
Che ruolo giocano i social e in generale il mondo virtuale?
«Credo che questa sia una questione su cui aprire tavoli di confronto e formazione, innanzitutto rivolti agli adulti. La cultura digitale ha cambiato il rapporto con la conoscenza, l’apprendimento e la definizione di sé e dell’altro. È innegabile quanto internet e il virtuale siano entrati a far parte del mondo di ciascuno, dal tempo libero, al lavoro, alla ricerca, al gioco. Ci dobbiamo fare i conti. La questione è come metterli al servizio della crescita e dei compiti evolutivi che il ragazzo è tenuto a compiere, avanzando verso la vita adulta, in modo costruttivo. Il rischio, ad esempio, insito nell’essere troppo precocemente esposti agli “schermi”, consiste nella tendenza a essere “catturati e raccontati” da altro o da altri, piuttosto che essere attivamente attori di una storia che parla di sé. Insomma, ci vogliono regole e istruzioni d’uso, non sempre facili da definire perché molto spesso siamo noi adulti disorientati da modalità e mezzi che conosciamo poco e ci intimoriscono. Dobbiamo “formarci”, avvicinarci al senso che l’esperienza virtuale rappresenta per i ragazzi. È come se dovessimo chiede loro «Come stai lì?» e «Cosa c’è lì di interessante o preoccupante?». Anche senza la pretesa che rispondano in dettaglio, ma rendendolo oggetto comune di scambio, per aiutare il ragazzo stesso a osservare, in modo critico, l’esperienza comunicativa. Da qui la “regolamentazione” – di tempi, modi, rischi, risorse – potenzialmente risulta più fattibile. Se ci pensiamo, il compito della mente adulta – genitori, insegnanti, educatori – consiste appunto nel fornire un luogo, un contenitore a supporto dei pensieri dei ragazzi stessi. Il negare una realtà che per il ragazzo rappresenta una parte importante della sua quotidianità rischia di indurre chiusure non di certo produttive. Resta comunque fondamentale, per il “ben-essere” di crescita, la questione di offrire al ragazzo alternative di relazioni reali, in famiglia, a scuola, negli oratori, nello sport. Invitiamo i ragazzi nel reale e facciamo loro compagnia, creiamo loro occasioni di incontro tra pari, così saremo tutti più pronti a usufruire in modo attivo del virtuale».
I ragazzi di oggi come stanno?
«Il tratto che contraddistingue sempre più le nuove generazioni riguarda il fatto di ritrovarsi spaventati dall’incertezza del futuro. Del resto, stiamo parlando di una generazione che ha, nel proprio bagaglio di sviluppo, episodi estremi quali la pandemia e la guerra. In aggiunta è come se, per contrastare questa fragilità, si chiedesse loro di essere iper pronti a tutto. O li si “iper-critica” o li si “iper-protegge”. Tutto “troppo”, avendo come risultato una dismisura. Li vorremmo autonomi ma non diamo loro strumenti per poterlo essere.
Necessita andare oltre i luoghi comuni che vedono i ragazzi di oggi o tutti svogliati o tutti incapaci o tutti sbagliati. Uno strumento che noi adulti potremmo mettere in campo è la curiosità di conoscerli davvero, di vederli davvero, non solo muovendoci cercando di controllarli o pilotarli. Sono difficili da raggiungere, è vero, e spesso vanno colti proprio in quei silenzi e in quei ritiri di cui parlavamo a inizio di questa riflessione. I silenzi dei ragazzi urlano e devono richiamare la nostra attenzione.
Un breve riferimento al contesto clinico: negli ultimi anni è stato rilevato un aumento significativo dei disturbi psicologici dei ragazzi, dai disturbi di ansia, dell’umore (depressione), ai disturbi alimentari, all’abuso di sostanze. Questa tendenza sottolinea quanto sia difficile il processo di formazione di un’identità solida e stabile per i nostri ragazzi. Ricordiamoci che l’adolescenza è sempre stata una fase delicata di sviluppo, ma con enorme potenzialità di formazione e definizione personale. Cresciamo nella “crisi” ma non significa che ciò debba svolgersi in modo patologico. I ragazzi hanno bisogno di ritrovare fiducia e passione verso la loro “storia” individuale e hanno bisogno dei nostri occhi come specchio per costruire questa immagine».
La pandemia ha avuto l’effetto di esacerbare situazioni di disagio già esistenti in precedenza. Come possiamo accogliere e guarire la sofferenza dei nostri giovani?
«Per accogliere la sofferenza dei ragazzi abbiamo davvero bisogno, innanzi tutto, di ristabilire un contatto con loro, di ascoltarli empaticamente, di costruire terreni di incontro. Compete poi a noi adulti – e ci aiuta – creare reti sociali virtuose, per leggere i loro bisogni e i loro desideri. Il riconoscerci, noi per primi, bisognosi dell’altro per assolvere al compito educativo, permette di aprirci alla possibilità di attingere ai differenti contesti di crescita.
“Per crescere un bambino ci vuole un intero villaggio” recita un proverbio africano. La domanda è quindi come costruire, nella nostra società, un villaggio atto a un compito tanto importante. Il chiedere aiuto, supporto al “vicino”, di cui ci fidiamo, è spesso il passo che ci conduce alla presa in carico di situazioni problematiche. A volte il vicino è la scuola, a volte il medico, lo psicologo, a volte il parroco, a volte un educatore. Ognuno con il suo bagaglio da condividere. Qualcuno che riconosce, con noi, la sofferenza ed evidenzia che si può, e si deve, fare qualcosa per stare meglio. E questo ci ricorda che, a nostra volta, possiamo essere “vicini” di qualcuno del villaggio. Una bella sfida. Una sfida per far crescere e crescere insieme».